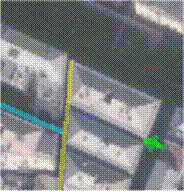ULANOWSKI
via
Walter Ulanowski
TARGA:
San
Pier d’Arena – via – Walter Ulanowski – caduto per la libertà – 1923-1944

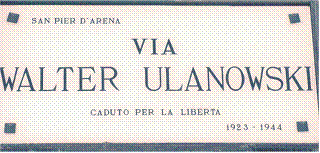
QUARTIERE
ANTICO: san Martino
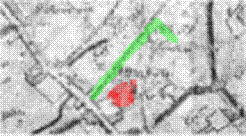 da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con
rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).
da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con
rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).
N°
IMMATRICOLAZIONE: posteriore
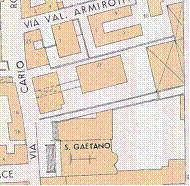
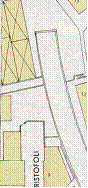 da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada
ancora non esisteva.
da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada
ancora non esisteva.
CODICE INFORMATICO
DELLA STRADA - n°: 62820
UNITÀ
URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO
 da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007
CAP: 16151
PARROCCHIA: san
Giovanni Bosco
STRUTTURA: strada
che si sviluppa ad L, dapprima rivolta a levante e poi a mare. Doppio senso
veicolare, da via C.Rolando, finisce chiusa con alcuni paracarri che la
separano da via P.Cristofoli, lasciando tra loro accessi interscambiabili solo
pedonalmente.
Nelle parte finale del primo tratto, caratteristico il
muraglione che probabilmente è vecchio di 4-500 anni essendo delimitante la
proprietà dei Pallavicini proprietari della ‘villa Bianca’ (comperata dai
salesiani e distrutta con metodi ...idraulici discutibili, per edificare una
delle palazzine attuali).
È
servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera
Nel
dic.03 ed ago.04 appare inclusa nell’elenco delle ’vie private di interesse
pubblico’ e quindi programmate a divenire municipali per acquisizione gratuita;
ma con in cambio avere diritto alla manutenzione ed ai servizi di asfaltatura,
spazzatura, fognature, illuminazione, ecc.
STORIA: nella carta
del Vinzoni del 1757, le proprietà terriere erano più vaste e non è facile una precisa
collocazione; ma la presenza del Tempietto (già cimitero) ci aiuta a scorgere l’esistenza di un confine tra il
terreno dei RR.Padri Teatini gestori della chiesa di san Giovanni Decollato (oggi san G.Bosco), e quello dei signori Ghezzi che avevano la casa sulla via
principale (allora anonima ma poi chiamata strada san Martino) nel tratto tra
la Nostra qui trattata e via V.Armirotti (anch’essa allora non esistente).
Nel 1872 appare aperta come sentiero; con -al di sopra –verso est-
dell’attuale limite della strada, la proprietà del marchese
Pareto.
Famiglia
Pareto = Possiedo molto poche notizie:
Antecedente, un Gio.Agostino,
del sec.XVIII, diplomatico genovese che al congresso di Vienna difese le
ragioni della Repubblica Ligure.
Suo figlio, Lorenzo
(Genova, 6.12.1800-19.6.1865). Fu anche lui statista, patriota e geologo. Nelle
sue biografie, nessun accenno a proprietà in SPdA; quindi non siamo sicuri sia
lui il vago “marchese Pareto” citato in tutte le carte e piantine (vedi quelle
dell’Ist. don Bosco). Dopo i primi studi in città, li completò a Siena e a LaFlèche
(Francia); tornò finito l’impero napoleonico dedicandosi –e divenendo un
esperto- a studi sulla geologia. Nel 1821 partecipò a dei moti insurrezionali
che lo costrinsero a tornare all’estero. Nel 1848 fu Ministro degli Esteri del
primo gabinetto costituzionale (presidente Cesare Balbo); l’anno dopo fu prima
deputato eletto a Genova; e poi presidente della Camera subalpina e infine
anche presidente della Camera dei Deputati. Fautore dell’annessine della
Lombardia, di Modena e Parma; nonché della 1ª guerra d’Indipendenza e del primo
tricolore da sventolare in battaglia, dopo Salasco si dimise assumendo
l’incarico di comandare la Guardia Nazionale di Genova fino al 9 febbraio 1849.
Trasferito a Torino con l’incarico di Presidente della Camera, tornò in città
schierandosi col popolo quando scoppiò la rivolta. Ciò malgrado fu amnistiato
da Vittorio E.II, riconfermato deputato e rieletto presidente della Camera. Nel
1861 senatore.
Importanti suoi scritti sulla geologia del Veneto, della
Liguria marittima, dell’Appennino settentrionale (in francese).
Corrispondenti alla data, esistono due – omonimi divenuti
famosi - ma ambedue antecedenti ad essa; quindi forse un nipoti del primo o
figli del secondo, Agostino (con
figli Lorenzo e Giovanna) e Giovanni.
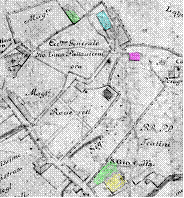 La loro villa invece, in una carta
del 1891 (nel libro di
don Bosco) appare
all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,
corrisponde (in viola –
non sono sicuro -)–per
posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà
dei sig.ri Ghezzi la
cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una
strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle
spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene
attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere
quella
La loro villa invece, in una carta
del 1891 (nel libro di
don Bosco) appare
all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,
corrisponde (in viola –
non sono sicuro -)–per
posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà
dei sig.ri Ghezzi la
cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una
strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle
spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene
attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere
quella
che spunta
a sinistra delle case nella foto -dell’area della Fornace - databile a pochi anni
prima del 1900.
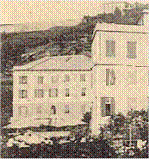 la villa come si intravede dietro la
casa
la villa come si intravede dietro la
casa
Quindi in successione, i proprietari= sig.ri Ghezzi (1875),
marchese Pareto (1890-nello stesso tempo in cui via san Martino
divenne via A.Saffi-vedi sotto a 1890), famiglia Landi (1930 ca).
Nel 1890, su delle mappe catastali, nella proprietà Pareto compare bel
definito il tracciato della nostra strada, sotto il nome di un “nuovo
passaggio di proprietà dell’Ospizio, acquistato dal Marchese Pareto”, poi ceduto dal Comune di San Pier d’Arena ai
salesiani, in precario di servitù di passaggio, per raggiungere dei terreni
ex-Pareto ed ex-comunali, siti alle spalle del cimitero ed acquistati dai
sacerdoti per allargare il settore femminile dell’istituto.
Verso il 1904 il marchese Pareto vendette il terreno alla ‘società
anonima Cooperativa di Produzione’ (questo nuovo organismo –nato a fianco della cooperativa di consumo per merito nato
dall’instancabile attività sociale di Carlo Rota e dei suoi successori (primo
ad esserlo fra tutti, fu Valentino Armirotti)- è il capolavoro della classe
operaia. Personaggi che proposero alla massa operaia, emarginata dal mercato
dei potenti imprenditori, di svincolarsi da loro che genericamente sfruttavano
la mano d’opera; un percorso tutto in salita per iniziare autonomamente una
attività produttiva, orientata sia verso la costruzione di case popolari per i
meno abbienti, sia per la produzione meccanica. L’operaio compie così un enorme
salto di qualità. A mio avviso è l’elemento base che ha dato forza alla classe
operaia; invece mai abbastanza è stato rappresentato, perché invece si
parla-si scrive-si vanta una ‘classe operaia’ sempre intesa come dipendente,
succube e passiva nell’iniziativa del lavoro, identificati nell’ esplodere
clamorosamente di rabbia negli scioperi. Invece no: la qualità e la dignità
degli operai emergono da queste iniziative che dimostrano la possibilità di
essere completi: imprenditori, produttori e consumatori autonomi perché
capaci). (il dBosco pag.52.57.61)
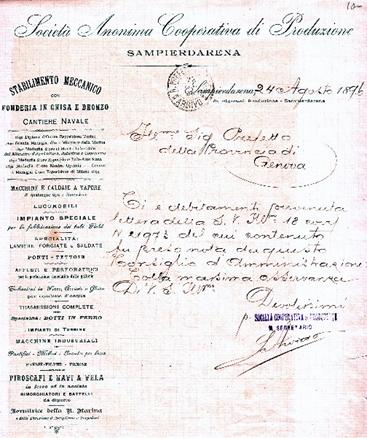
Un
terreno, che da coltivo diviene costruttivo e cementificato: nel 1905
compare sulle carte il nome alternativo di ‘società metallurgica’
In seno all’«Ass.Gen.M.Soccorso e Istruzione degli Operai di
SPd’A.» nacque nel 1864 la «Soc.Cooperativa di Produzione e Consumo di SPd’A».
Mentre prendeva avvio subito l’offerta in campo alimentare (Produzione di farine, pane, pasta;
consumo di tutti i più vari generi alimentari), occorsero
vari decenni perché si allargasse l’attività all’edilizia (1875; nel 1895 la coop. era
presieduta dall’ing. Brenno Salvatore; eletto al Comune, la società fu posta in
liquidazione nel 1899) ed alla meccanica: quest’ultima è
poi rimasta per antonomasia il sinonimo di “Produzione” o “Meccanica”.
L’attività col metodo Cooperativo trovò proliferazione,
coinvolgendo numerose categorie di lavoratori (muratori (1897), ferrovieri (1897), turacciolai,
falegnami, spazzini, pescatori, ecc.) e creando un vastissimo tessuto, curato con congressi e
convegni svolti anche nella nostra città –divenuta culla di questo movimento-,
mirato a proteggere il più possibile le varie categorie stesse fino a creare
una “Lega nazionale delle soc. Cooperative”. A fine secolo in SPd’A esistevano
le tre principali, nate dall’Universale (Produz.
e Consumo; Case economiche; Meccanica) e
la “Consumo LigureLombarda”.
La Produzione meccanica, nacque come idea il 12 ottobre 1873
nella sede dell’Associazione Universale Operaia, quando rimasero senza lavoro
ben 400 operai dell’Ansaldo, su idea e proposta del socio Piero Botto. Promosse
di aprire un’iniziale fucina in cui potessero lavorare gli operai
disoccupati. Quando dopo 10 anni si stilerà uno Statuto, al primo articolo si
porrà lo scopo: «...raccogliere i mezzi sufficienti per l’impianto di un
opificio meccanico o d’altro genere di lavoro, onde togliere la preponderanza
del capitale sul lavoro, emancipando l’Operaio col renderlo compartecipe
all’utile.» L’anno dopo 1874, sotto una tettoia nei giardini a fianco
della Coop. di Consumo e con strutture molto modeste, il primo operaio che
iniziò a lavorarvi fu Gerolamo Bagnasco (detto ‘Giromin’),
aiutato dall’attivissimo Pilade Derchi e dagli altri soci che li affiancarono
nelle ore libere e la domenica; la tettoia divenne un baraccone chiuso (Giromin, diventato maestro, dopo
aver assunto incarichi organizzativi e preparatori nella società, non seguì
sino in fondo le sorti della Coop. ma, dopo la sistemazione di essa in via A.Saffi, si mise in proprio rilevando un laboratorio, aperto nei
palazzi vicini)
Con le quote versate dai soci, nel 1883 (Tringali
scrive 1882) la Coop. poté costituirsi legalmente: scrivendo uno statuto «con
lo scopo di usare i propri risparmi per impiantare un opificio meccanico,
emancipando l’operaio con il renderlo compartecipe all’utile»; chiamandosi
‘società anonima Cooperativa di Produzione fra gli Operai in San Pier
d’Arena’; affittando e trasferendosi in locali più ampi in via Battista Agnese
(poi successivamente distrutti a favore delle case da abitazione attuali), con
reparto di tornitori, calderai, aggiustatori meccanici e fonderia.
Nel 1886 ha già 530 soci. 1887: la Coop
aumenta i soci, arrivando a 627, e muta nome in «Soc.An.Cooperativa di
Produzione». L’evento è stato reso possibile dall’aver occupati cento operai,
aver ottenuto importanti commesse dal governo, da privati, dalla consorella di
Consumo (un mulino a
vapore da 50cv), e
subappalti. Viene nominato ingegnere tecnico Torriani Davide (che nel 1907 aprirà uno stabilimento
proprio chiamato Acciaierie e Fonderie Liguri, vedi a via s.Fermo). Viene
affittato un locale nella strada oggi via G.Buranello, di 1200 mq dalla ditta
Franchini per creare l’officina dei calderai.
Marzo 1889; l’apporto di commissioni provenienti anche
dalla Marina militare (caldaie e natanti in ferro) contribuì ad aumentare il
lavoro ed i soci (oltre 700).
Nel 1890 immobili ed impianti valevano 27mila lire:
non grandi capitali quindi, se confrontati con la vicina azienda meccanica
Storace con capitale 60mila e con l’Ansaldo milionaria) ove lavoravano oltre
100 operai, con un dividendo negli anni 1887-90 del 10%.
Nel 1892 l’incremento del lavoro e degli occupati,
determinò la ricerca di nuovi spazi; pressati non si sa da quali urgenze
(spazio o sfratto), occuparono inizialmente un terreno ove ora scorre via
B.Agnese, allora ancora prati incolti al bordo dei giardini. Il 1892 fu anno
delle feste colombiane, re Umberto I venne a Genova a visitare l’esposizione ed
approfittò per ammirare la produzione meccanica genovese (Lamponi dice che
venne anche nell’opificio operaio, e compiaciuto comprò con gesto di fiducia
un buon numero di azioni societarie a titolo investimento privato). Dopo pochi
mesi, nell’anno dopo:
1893, si ritrasferirono definitivamente in via A.Saffi 27
(v.C.Rolando, al di là del vicoletto anonimo chiuso in fondo dai muri dei
salesiani, posto a nord del tempietto-cimitero di san Gaetano; ed ivi restò
fino agli anni del 1950. Diretti da Fossati, resero la coop capace di rilevare
alla spiaggia del Canto della città un cantiere navale acquistandolo (Tringali
scrive che fu Giromin ad acquistare per se stesso il cantiere, poi si
smentisce) dalla ditta Baracchini e producendo così anche piccoli natanti e
loro parti. Avvenne così il primo varo di un rimorchiatore interamente
realizzato dalla coop. (dall’elica, al motore, lo scafo).
1897, gli operai occupati arrivarono a 177. Direttore fu Eugenio Broccardi
(?-pag.58 del libro 2421)
1906 gli operai occupati arrivarono a 244; gli uffici erano in via V.EmanueleII (via
G.Buranello) e la società si autodefiniva di
‘costruttori meccanici e navali’. In questo anno, subì l’inflessione
coinvolgente la cantieristica con alcuni anni di crisi e licenziamento di un
quarto dei lavoratori.
Pare che nel periodo bellico del 1915-18, abbia
anche prodotto cannoni. Nel
Pagano/1920 la leggiamo sempre nelle due sedi: in via A.Saffi 27 ed in
via Vittorio Emanuele non specificato dove.
Nel 1926 ne erano direttori gli ing. Eugenio Broccardi (nel 1920 è anche consigliere provinciale)
e Luigi Derchi; con loro l’installazione di sempre più attrezzati impianti e
l’acquisto di un modesto cantiere navale, riuscendo ricevere importanti
commissioni: costruire rimorchiatori in acciaio, motori a vapore per grandi e
piccole navi, ponti in metallo, grosse barche, ed altre strutture importanti in
ferro e acciaio.
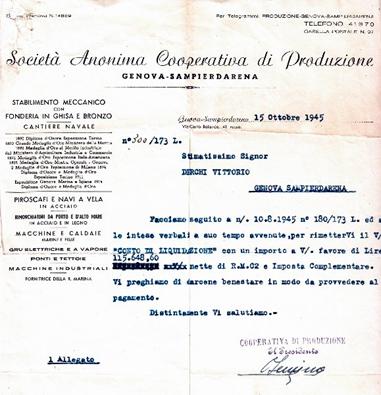
Nel 1957, quando dava lavoro a 120 soci, per una
ennesima crisi nel settore, e per concomitanti circostanze negative, cessò la
produzione malgrado lo statuto indicasse che ‘non può cessare di esistere che
per cause di forza maggiore, né potrà sciogliersi se non verificandosi perdite
considerevoli.
Dal 1905 quindi, il viottolo rimase “privato”, e chiuso alla fine: non appare
aver mai ricevuto un nome ufficiale rimanendo diramazione di via C.Rolando, ove
aveva apertura il civ. 19.
Solo nel gennaio 1963, eliminato lo stabilimento metallurgico, sul terreno
–messo in vendita per 200milioni- furono costruite a nord le case attuali che
si aprono col portone nella galleria (che fa parte di via C.Rolando); con esse
e col recupero comunale della strada, ne derivò in quell’anno dal Consiglio
Comunale la titolazione al partigiano.
CIVICI solo pari e
progressivi (senza rossi e neri)
Anno
2007*: = da 2 a 58 (mancano dal 42 al 46)
Acquisita
autonomia, cambiarono i primi civici: da civ. 19 nero di via Rolando a civ. 52;
il 67rosso divenne 54.
===civ.
14r apre con breve rampa in discesa, a dei box sotterranei
===civ.
si aprono i vani degli uffici postali, con ingresso anche nella galleria.
===civ.
52-4 presso il muro che delimita a nord la proprietà, ha posto una piccola
lapide a ricordo di quattro dipendenti morti nel conflitto: “La Coop. di
produzione ai suoi caduti di guerra 40-43 - Assereto Riccardo, Lanza Guido, Morchio
Giulio, Neri Aldo . 4/6/55 “.
===civv.
56 e 58 furono assegnati successivamente (1967) alla scuola liceo scientifico E.Fermi.
Edificato sul terreno ove finiva la fabbrica di carpenteria meccanica e sul cui
retro scorre la ferrovia (che va dal parco del Campasso al porto in zona Di
Negro tramite la galleria dei Landi). Nato nell’ottobre 1960 come succursale del liceo scientifico genovese “Cassini”, ed
ospitato dapprima nei locali di via Chiusone, nel 1961
(altrove si scrive con l’anno scolastico 1962-3) divenne autonomo sotto la
presidenza del prof. Orzalesi. Gli studenti, sempre numerosissimi, provenienti
per la maggior parte da famiglie operaie, hanno spesso rappresentato la
cosiddetta ‘scuola calda’, ovvero sempre in primo piano nella ricerca di nuovi
impegni scolastici, anche se troppo spesso politicizzati a senso unico, in
parallelo alle tensioni sociali dell’epoca. Nel 1970
fu aperta una succursale a Teglia. Nel 1989 si
gemellò con il liceo scientifico francese di Nantes; altri gemellaggi e corsi
estivi all’estero completano l’insegnamento aggiornato. Nel 1993, unico in Liguria e fra 11 in campo nazionale,
scelse di aggiungere l’aggiornamento telematico e dei laboratori; così oltre
all’indirizzo ordinario ha come sperimentali un indirizzo bilingue,
naturalistico, sport e spettacolo, PNI. Ha una succursale in via Rolando,12.
Nell’anno
scolastico 2006-7 si scrive che, causa il
numero degli iscritti, quattro classi (90 studenti) sarebbero state trasferite
in via Dino Col (dove
già sono l’Abba-geometri e GastaldiGiorgi-industriale); e quando alcuni del Fermi erano già ospiti presso
la scuola media Barabino, di via C.Rolando, ed altri al liceo classico Mazzini
di via SPdArena (sic
sul Secolo; il ‘classico’ è nei giardini Pavanello-vPReti).
Nel
2007 appare composto da sede direzionale in via Ulanowski 56, tel 010
645.1229; tre succursali (via C.Rolando 12, via P.Reti 25,
via D.Col 30/32) e quattro indirizzi
sperimentali tutti
convergenti nella maturità scientifica (bilingue, naturalistico, sport e spettacolo,
PNI)-. L’intenzione è però accorpare
tutti alla ex-marittima, via Cantore-Milano non appena ristrutturati i locali (acquistati dalla Provincia per
8milini di € ed affidati alla impresa Davide Viziano). Nel 2009 si apprende
che la succursale utilizza la palestra dei VVFF non potendo usufruire della
propria.
DEDICATA al
partigiano triestino, figlio di Casimiro e Pecenco Giuseppina là nato il 6
lug.1923, studente della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di
Genova , antifascista per ideologia politica acquisita in casa e negli studi.
Si dedicò dapprima a fare propaganda avversa al regime fascista finché nel
gennaio 1944 fu costretto alla fuga in montagna per non essere arruolato di
forza . Ben presto, dopo pochi mesi sui monti, acquistò fiducia e capacità
divenendo capitano nella ‘3.a brigata Liguria’ ed assumendo il soprannome di
“Josef”. Ricevette poi l’incarico di ufficiale dello stato maggiore.
Durante un rastrellamento nella zona delle Capanne di Marcarolo, nella Pasqua
del 1944, il 10 aprile fu catturato e trasferito a Marassi (la primavera del ’44 era stata
particolarmente feconda di arresti: da renitenti ai bandi di arruolamento, dal
raffreddato consenso degli operai alla lotta clandestina organizzata, dalla
disorganizzazione dei molti avversi al regime che operavano in nuclei slegati
come il VAI, la Giovine Italia, gli appartenenti alla OTTO ed i partigiani
stessi di città e sui monti rastrellati).
Il 15 maggio successivo, un attentato
gappista (deciso in una
riunione svoltasi a SanPierd’Arena e presieduta da Germano Jori, mirato a
trattenere notevoli forze nemiche in città per presidiare i punti nevralgici,
creando in loro insicurezza e demoralizzazione), provocò nel cinema Odeon di via Ettore Vernazza in Portoria la morte
di quattro soldati tedeschi ed il ferimento di altri sedici, di cui quattro
gravi (il locale, era
stato requisito ed adibito ad esclusivo uso delle truppe tedesche con
proiezioni nella loro lingua e rigorosamente vietato ai civili italiani; dei
militari controllavano rigorosamente tutti quelli che entravano ed uscivano dal
locale; una bomba a miccia lenta fatta di un kg. circa di tritolo compresso in
un tubo di acciaio, nascosta in una borsa fu introdotta da un gappista rimasto
anonimo, travestito da ufficiale tedesco; fu fatta esplodere alle 19,30 durante
la rappresentazione di un film).
Fu posta una taglia, enorme per allora: 3 milioni di lire.
La rappresaglia, sulla base del 10 italiani per ogni tedesco voluto da Hitler, già adottata a Roma dopo
l’attentato di via Rasella di due mesi prima, determinò il giorno dopo (16 maggio) un processo del Tribunale Speciale ed
il 17 la definitiva modalità: condanna a
morte dei detenuti, nonché luogo e modalità di esecuzione (la più totale segretezza per evitare
disordini ed altre rappresaglie in città: dovevano essere giustiziati lontano,
in luogo appartato e nascosto; si dovevano seppellire le salme da non doversi
sapere dove fossero. Avrebbero dovuto essere 40; poi 50 perché un ferito morì
nei giorni seguenti; divennero 59 non si sa perché (o sbagliato il conto, o i morti
tedeschi furono sei e non cinque; il 60°, Ricci Raimondo (88enne nel 2009),
allora sottotenente assegnato alla Capitaneria di porto di IM; catturato e
trasferito dopo spiata di un marinaio; ebbe salva la vita miracolosamente (dopo
essere stato incluso nell'elenco, non fu chiamato nel contro appello: mai si è
saputo perché; trasferito a Mauthausen; divenuto poi penalista e parlamentare
del PCI). In totale 42
politici più 17 partigiani superstiti da Pasqua dalla Benedica, tutti praticamente
già condannati a morte
(bugia, perché non tutti già processati). Gli scavatori della fossa furono inviati sul posto scelto il
18 mattino (una squadra
di ebrei, poi fatta rientrare di notte tenendola segregata). Fu scelta la località detta Fontana
Fredda (altri scrive alture di Riofreddo; poste tra la galleria del Turchino
ed il valico a 542 m slm; era raggiungibile con una mulattiera che poi arriva
alla Cappelletta di Masone; fu suggerita da qualche ufficiale che era stato a
controllare le postazioni militari sul passo)).
Il 19
maggio 1944, immaginando la sentenza, commoventi risultano le lettere
che il giovane scrisse, con pacata e controllata emotività ma di forte
carattere, ai suoi più intimi parenti. Il ventunenne Ulanowsky – fu caricato
prima dell’alba con i compagni (assieme - ed anche a lui è stata dedicata una strada sampierdarenese-
c’era il 19enne Bruno Ghiglione) su due
corriere di linea sequestrate appositamente. Sorvegliati da circa 200 tedeschi -
delle SS e di soldati della marina (Kriegsmarine) - più vari italiani
simpatizzanti, furono trasportati nella località, legati due a due; ed in
un’ora e più, avvenne la fucilazione di 59 prigionieri
Prefetto a Genova era
Emanuele Basile e, da parte tedesca, deus ex machina fu Friederich Engel,
comandante della Sd (la polizia delle SS) che alla fine degli anni 90 fu
condannato (morirà nel 2006, a 95 anni) nel 1999 (?) a 4 ergastoli dal
tribunale militare di Torino (mentre il tribunale tedesco di Amburgo lo aveva
condannato nel 2003 a otto anni di carcere; ed a Dresda fu disposta
l'archiviazione essendo prescritto il reato).
Sui giornali, il giorno 20
apparve un laconico comunicato segnalante che “59 comunisti e dinamitardi
erano stati giustiziati all’alba del giorno 18” dando il fatto per già
compiuto due giorni prima, anziché uno (i
familiari, sapendo vivi il 18 i propri congiunti prigionieri, poté dedurne
erroneamente che la fucilazione non era toccata a loro; il padre di Walter,
Casimiro, seppur conosceva il tedesco più volte si scontrò con un muro di
silenzio e di paura). Cosicché solo dopo il 23
i familiari iniziarono ricerche in quella direzione seguendo vaghe indicazioni,
bisbigli e notizie sussurrate. Finché non identificarono la zona e, dolenti,
riesumarono le salme per il riconoscimento (ben
12 non furono identificate). Alzarono sul posto una croce in alluminio e
poi un sacrario. Le salme dei caduti dapprima furono composte nella terra
stessa dell’eccidio; poi trasferite nella cappelletta di Masone; e solo il 20 giugno del 45 dapprima trasportate nella
parrocchiale del paese, poi a Genova da dove ognuno seguì la via indicata dalle
famiglie.
Nella lunga poesia intitolata “i fucilati del
Turchino”, Carlo Pastorino, pubblicata il 22 giugno
1945 sul quotidiano genovese “il Nuovo Cittadino”, fa cenno al ragazzo
come rivolgendosi al padre: “Bevettero (sic)
i cari martiri del Turchino la loro ultima luce nel profumato mattino di
maggio:…e anche era con loro, o Ulanowski, il tuo figliuolo, il tuo figlio
della grande e sventurata nazione polacca; …”.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale -
Toponomastica , scheda 4509
-AA.VV.-Annuario guida
archidiocesi-ed.1994-pag.450; ed.2002-pag.487
-AA.VV.-Contributo di SPd’A
alla Resist.-PCGG.1997-pg. 50.75.133.152
-AA.VV.-Il donBosco nella
storia urbana-DonBosco.1997-pag. 34.57.61
-AA.VV.-35°
SPd’A
-Bampi&Oneto-l’insurrezione
genovese del 1849-IlCerchio2010-pag 122
-Castronovo V-Storia
dell’Ansaldo- Laterza 1994- vol.I-pag.162
- vol.II-pag.87.202
-DeNicola F-La letteratura
nei giornali genovesi..-DeFerrari.1996-pg.63
-Doria G.-Investim. e
sviluppo econ. a Ge.-Giuffrè.1973-vol.II.pag.769
-Enciclopedia Sonzogno
-Gazzettino Sampierdarenese
: 3/84.5 + 1/86.1-7 + 2/86.2.3 + 3/89.4 + 5/93.3 + 6/94.9
-Genova,
rivista del Comune: 3/56.2foto
-Gimelli G.-Cronache militari della
Resist.-Carige.1985-vol.I-pag.236-8
-Il
Secolo XIX : 25.11.03 + 23.08.04 + 15.10.06 + 19.11.09 + 24.5.09
-Lamponi
M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.127.157.165
-Miscio
A.-La seconda Valdocco-Elledici.2002.vol.I-pag.105-vol.II.pag347
-Morabito
L.-Il mutuo soccorso-Ist.Mazziniano.1999-pag.343
-Pastorino&Vigliero-Dizion.delle
strade di Ge.-Tolozzi.1985-pg.1397.1792
-Poleggi E. &C-Atlante
di Genova- Marsilio 1995- tav.21.22
-Tuvo&Compagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.266
UMBERTO via Umberto I
Corrisponde alla attuale via P.Reti-W.Fillak .
Finché per secoli e secoli
dall’epoca romana, la strada ufficiale per uscire da Genova fu quella a monte,
che passa ora a livello del cimitero della Castagna, il tratto stradale
fondovalle, parallelo al torrente fu inesistente o comunque in totale disuso se
non per traffici e scambi locali che avvenivano transitando generalmente per
il primitivo antico asse centrale del borgo (via DeMarini-via Daste-viaRolando-via Campasso).
La viabilità subì un netto miglioramento dopo il 1630
con le ultime mura ed il nascere della strada dalla Lanterna. Da questo nuovo
asse viario, per arrivare a Rivarolo si potè iniziare ad usare sempre più sia
la antica direttiva al centro del paese che quella nuova lungo il litorale; ma
ambedue in zona Mercato si congiungevano e per arrivare alla parrocchia (san
Martino) e Rivarolo, unica strada era l’attuale via
C.Rolando.
Solo dopo il 1700 in quest’ultima direzione si migliorò la
viabilità lungo il torrente (fu a spese personali del doge G.B.Cambiaso, poiché
era per proprio interesse: poter raggiungere le proprie tenute a Rivarolo ed
oltre).
Aperto questo esercizio,
anche il commercio, ne trasse vantaggio. La nuova strada fu però percorsa nei
due sensi più volte anche dall’ esercito austriaco in aggressione di
Genova.
Solo a fine dell’epoca napoleonica - e poi ancor di più
con i Savoia - le condizioni di mantenimento stradale migliorarono; così
iniziano a metà del 1800 le prime denominazioni delle strade più importanti e
di maggior conoscenza popolare ( vaghe indicazioni legate a punti di
riferimento di rilievo, non ancora ufficialmente denominati); tipo – per la
strada in trattazione - “stradone della Palmetta” e poi dopo dal Porro: “strada
reale di Torino”, e dall’ Alizeri: “strada Nuova provinciale”.
Nelle carte, questi nomi
persistono a lungo, anche oltre la nominazione ufficiale del regio decreto del 1857,
che finalmente riconosce il nome di “via Vittorio Emanuele” (comprendente tutto il percorso, dalla Lanterna a
Rivarolo, particolareggiando il tratto, come ‘via Vittorio Emanuele alla
Palmetta’ ).
Nel luglio del 1900, con l’assassinio del re Umberto I, il
solo tratto - lungo un chilometro e cento metri
circa, da piazza V.Veneto a Certosa ed oltre -, fu dedicato al re
ucciso. In quell’epoca per la prima volta fu applicata in modo più razionale
anche una numerazione civica, e fu chiarito il modo ufficiale il confine tra la
città di San Pier d’Arena e Certosa (dalla
strada al torrente Polcevera fu specificatamente titolata una “via del
Confine” oggi via
G.Frassinello); e dalla strada al
colle, fu indicato il torrente che dall’alto scende fino a via Brin (oggi,
dalla metropolitana).
Nel periodo in cui fu applicata la tassa del dazio - fino all’ ultima
guerra -, il casotto – per ragioni di spazio di collocazione - fu posto a mare
del cavalcavia ferroviario, ma ancora il confine era cento metri più a nord (un altro posto
di controllo fu istituito in alto, a forte Crocetta).
Per motivi non conosciuti – forse numero di abitanti - dopo l’ultimo
conflitto mondiale il confine è stato per noi accorciato, passando ora per via Campi ed il ponte
dell’Autostrada (ed escludendoci l’ultimo tratto di via W.Fillak, metà
via del Confine, via M.Bercilli e via A.Ristori, via Pietra, tutte allora di
nostra competenza).
Appena denominata, un
censimento delle case esistenti al fine di elaborare anche la numerazione (che già preesisteva ma appartenente alla più lunga via
V.Emanuele, per cui il civ.1 attuale corrispondeva al 30 della precedente),
vedeva, dapprima il tratto oggi via P.Reti: sul lato destro
al civ.1 (ex 30) casa Castello; al 2,3,4 casa Carpaneto (ex 31);
all’angolo con via san Cristoforo il civ.5 di Chiesa e C, e di fronte
casa Razzetti al civ.6 (ex 33); civ. 7 assegnato nuovo
all’ingresso stabilimento Tramvai; civ.8 alla
‘casa d’abitazione del Tramvai’( ex 33B); civ. 9 (ex 33C) ingresso stabilimento Torriani (aperto nel 1895, con indirizzo di stabilimento meccanico navale, arrivò
ad avere 200 operai quando, in espansione, si aggiunse un secondo fabbricato
“per l’impianto di macchine perfezionate per l’esecuzione dei lavori secondo
gli ultimissimi sistemi e le migliori regole dell’arte”); civ 10 (nuovo) all’ingresso stabilimento Repetto a me sconosciuta la sua
funzione; civ. 11 (ex 34) alla casa custode giardino; civ 12 (ex
34K già ingresso dello stabilimento Produzione) alla casa Franenini; civ. 14
(ex 34A) casa Galeazzo; civ.18 (ex 34B) casa Movegno. Sul lato sinistro civ 13 (ex
34D) casa Guiducci; civ 15 (ex 34E) casa Morando fabbrica mole; civ.16
(ex 34L) ingresso stabilimento Sasso; civ.17 (ex 34F) casa Sasso (evidentemente
in via WFillak ancora non c’erano case).
In corrispondenza, nel Pagano 1902 «ne compare solo uno perché, gli
esercizi commerciali sono ancora alla voce via Vittorio Emanuele: all’ 1 Rolla Vittorio e Rolla E. separatamente sono commissionari e rappresentanti, si
interessano di articoli tecnici, oli e grassilubrificanti, e fabbricano cinghie
per trasmissione, lavorano ferro-acciaio-ghisa, filetti per macchine. tel
813;---
Nel Pagano 1908 compaiono
nella via al civ.5 il ferramenta Serra
Ercole;--- al 20 la farmacia di Grosso Agostino (nel 1919 il civ. è divenuto 29
ed il farmacista successore fu Lanfranchi Filippo con tel 44-95).
Civ
non specificato, la sede di un impresario edile tal Merlo Bartolomeo;--- il
venditore di automobili Campora Antonio;
Viene descritta l’esistenza di un ‘cinema Eden’ , con
sala per solo 50 spettatori, aperta negli anni attorno al 1910, cinquanta metri
dopo verso Rivarolo rispetto all’attuale collocazione del ex-cinema Massimo
(allora cinema Verdi); fu chiuso nel 1918.
La strada compare
ufficializzata nell’elenco delle strade, pubblicato dal Comune nel 1910:”da sotto il passaggio Umberto I al
confine territoriale con Rivarolo Ligure” (ovvero
dal sottopasso ferroviario di piazza VVeneto); aveva civici sino al 62 e
65.
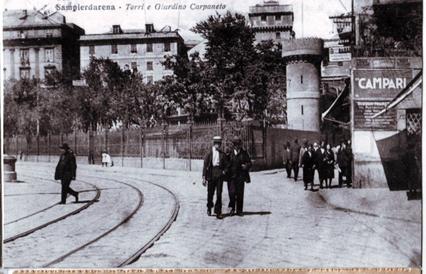
a
sinistra, inizio di via Umberto I con eculissi del tram; a destra via N.Bixio
Nel Pagano 1911 e 1912
sono citati al civ.5 negozio
di ferramenta di Serra Ercole; Robba Andrea (→’25 civv. dal 9r al 15r)
di casalinghi e chincaglieria; al 18 la levatrice Ferrarini Luigia; al 19 (dal 1912 al
‘25) la levatrice Migliara Carolina; al 29-6
Brizzolara Emilio esercita ancora nel 1925
da dentista; al 32r rivendita pane di Parodi
Giacomo, al 34r di Derchi
Marcello;
al
45r la Coop. fra muratori ed affini
dell’edilizia (tel. 3778 – nel
1904 fanno reclame sul giornale “L’azione socialista” specificando avere sede
in piazza Omnbus; nel 1905 assunsero l’incarico di restaurare il palazzo del
Monastero (vedi) prevista sede del Municipio; nel 1908 il Pagano li descrive in
via Vittorio Emanuele al civ. 8r sotto la ferrovia ed attivi nell’erigere la
vasca di piazza Settembrini (vedi); nel 1913 pubblicano il bilancio consuntivo
dell’anno: presidente Repetto Giovanni, ha un movimento di £.1105,60 con un
utile di 209,65);
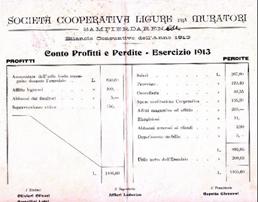
al
48r Bottaro GB; al 55
(dal 1912) la levatrice Pedrini Carolina;
al 59 rivendita di pane (di Bagnasco
Maria, al 60 delle sorelle
Lonzi);
(i
numeri a seguire, il Pagano li colloca sempre a Sampierdarena)=al 67r di Franzone Paola; al’83r
Porcile Gaetano (Giacomo) ha un negozio di commestibili e rivendita pane; forni (all’88r il di Melchiore Elisa, al 102r
quello di Cocchiano Emilia, al 128r quello di Goffi Natalina, al 130
e 243 r di Moscato Feder.; al 173r di Colombato Teresa ed al 211r
quello di Penna Malvina); 163r la Coop.Ligure Lombarda (anche in via
Daste 46r);
Non
specificato il civico: Sobrero Antonio di cartoleria; la farmacia san Martino del dr. Caraccino; Bertorello Remo ha un negozio di articoli tecnici
tipo cinghie per trasmissione (e deposito di quelle di pelo di cammello)
macchina per filettatura; corderia Nazionale Carrena e
Torre ha fabbrica, macchinari ed un deposito aperto; Morando Giuseppe (in altre righe è Francesco),
tel.937, fabbrica cavi ed altri lavori in crine; gli eredi Merlo Bartolomeo gestiscono una impresa edilizia;
un libraio Vernazza e Zai; Campora Antonio che vende velocipedi; Lucotti Paolo, tessuti; la ‘Coop Muratori ed affini’ quale impresa edilizia; Moris Gaetano panettiere; G.Gatto
& figli (nome rilevato su una cartolina postale il cui timbro
postale è di Rivarolo- “fabbrica botti e tini, fusti per esportazione per
liquidi ed imballaggi; riparazioni a domicilio e in Stazione Ferroviaria”; vedi
1933).
Nel 1915 il notaio Bonini ha ‘di fronte’ in una
lite, Emanuele Vittorio Parodi, presidente della soc.an. Corderia Nazionale già
Carena e Torre, e Pasquale Merlo, per questioni di immobile sulla via (vedi a vico Chiusone).
In una seduta straordinaria
del Municipio, datata 31.3.1921, si decise l’aumento delle tasse agli
stabilimenti sampierdarenesi aperti sulla strada: al
civ. 16, Sasso fratelli, lavorazione
lastre e tubi in piombo (ove ora è Metallegno). Un loro opuscolo indica la stessa strada, ma il
civico 10, telef. 16-47 (vedi via P.Reti); civ. 20 spa Commercio Metalli
e Ferramenta¨ ; civ.41.43r. la soc.an. già Torriani
fu Davide, fonderie e officine meccaniche e cantiere (ove ora è l’AMT, a monte).
Non
specificato il civico: soc.Corderia Nazionale Carrena
e Torre (con sede a Genova, e deposito aperto, che nel 1908 fu in via
UmbertoI, poi in piazza Palmetta);
soc. Unione Italiana Tramways Elettrici (ove
ora è l’AMT, terreni a mare); soc.an.Gio Ansaldo macchine agricole; cinematografo Eden (di Parodi B e C.); negozio di
chincaglierie di Robba Andrea; negozio di calzature di Porta Primo; negozio di
cinghie per trasmissione di Remo Bertorello;
Nello stesso anno la stessa Giunta deliberò anche il
cambio del nome, mirato ad onorare –come in tutta Italia, con grosse, imponenti
e solenni onoranze- il nome del Milite Ignoto (vedi).
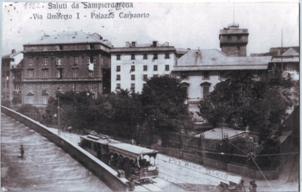

1917 – collez. Canepa
Ma
ancora nel Pagano 1925-6 compaiono indifferentemente come via
UMBERTO I (UI) e come via Milite Ignoto : civ. 10 i succ. Morando che ancora nel ‘33 si interessano di macine
per molini; -civ. 19 levatrice Migliara Carolina ed i successori (UI)
della vedova G.B.Repetto,tel 849, in una officina meccanica;- civ. 20 la
Società Commercio Metalli e Ferramenta, tel.41-373;- civ. 31r Piccardo Bartolomeo di Filippo ha negozio di ardesie
e materiali da costruzione (poi andrà a finire in via Pastrengo-v.Stennio);- civ.40
il Linificio & Canapificio Nazionale (stabilimento di Sampierdarena),
fabbrica di cordami, spaghi e corde per imballo, tel, 41139;--- civ. 44r
“la antica farmacia Sibelli, di DeBernardis
Giuseppe (civ.18 tel. 45-25) nel 1919§; e di Mauro Giuseppe nel 1925, tel
41169);- civ.54-1 levatrice Pedrini Carolina;- civ. 89-91r la farmacia “Lanfranchi Filippo (Laboratorio chimico
farmaceutico, tel 41242);- civ.168r impianti elettrici di Tronca
Umberto-; civ. 181r negozio di tesuti di Caratti Caterina;--- civ. 265r
Pellegrini Michele ripara copertoni-; civ. 267-271r: alla voce
‘velocipedi’, una “Agenzia Sportiva”;-
Non
specificato dove: levatrice Pambianchi Emilia---; impresa edilizia degli eredi
Merlo Bartolomeo---; Gotti Lisandro ha negozio di macchine per cucire (‘vicino
al deposito tramway’=forse il negozietto all’angolo con via Stennio)---; Lucotti
Paolo negozio di tessuti---;
Ancora
nel Pagano 1925 si segnala in più, al civ. 168 il terzo calzaturificio nella via,
questo di Tronca Angelo; al 163r il negozio commestibili della Cooperativa
Ligure Lombarda
Quando nel 1926
tutte le città vicine a Genova furono assorbite nell’unico comune della Grande
Genova, numerose erano le delegazioni che possedevano questa titolazione si
programmò sostituirne il nome (Apparizione, Bolzaneto, Centro, Bavari, Borzoli,
Cornigliano, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto, Quinto, Rivarolo, SPd’Arena
(di 2a categoria), S.Quirico).
La strada aveva lo stesso nome
Umberto I ancora nel 1933 quando fu
appaltata la pavimentazionecon lastroni di porfido preventivando una spesa di
1milione100mila lire; in effetti con una spesa di 600mila lire venne completata
fino al confine con Rivarolo (e continuata oltre
con altrettanta spesa) la lastricatura con masselli di granito, posti su
apposito sottofondo di calcestruzzo (nella
delibera, la via viene ancora genericamente chiamata ‘via dei Giovi’ oppure
‘per l’entroterra’).
Già vi esistevano le tre
farmacie ( la Sibelli
di G.Mauro al civ.40; la Failla già Lanfranchi
oggi Croce d’Oro al 107 ; la san Martino
di A.Perrone al 96. Però in un elenco non datato, al civ.18 viene
segnalata una quarta farmacia di proprietà del dott. Bernardis
Giuseppe); dal 9r al 15r il chincagliere-articoli
casalinghi Robba
Andrea; al 10 il bottaio Gatto Giuseppe ed la
succursale di macine per molini di Morando¨;
il cinema Verdi; al 20 la soc. Commercio Metalli e Ferramenta (fabbrica e negozi); al 54 era il
Linificio e canapificio Nazionale, sede/Milano (fabbrica cordami e spaghi-funi
metalliche); al 215r calzaturificio di
Porta Primo; al civ. 235r l’Azienda Autonoma
Annonaria cittadina (per la vendita di
generi alimentari di prima necessità, a prezzi minimi); 265r negozio di cereali di Rabbino Amilcare e di riparazione copertoni di
Pellegrini Michele; al 267.269.271r l’agenzia sportiva di Velocipedi.
Non precisato dove: la fabbrica di cinghie per trasmissione di Bertorello Remo; calzaturificio Torinese (dal 1925 ha anche una sede in piazza Ferrer);
il negozio di idraulica-elettricità-casalinghi
dei f.lli Curti; il negozio di articoli tecnici di Bertorello Remo; i
costruttori edili ‘Eredi Merlo Bartolomeo’. .
La giunta sampierdarenese
decise mutare il nome in ‘via Milite Ignoto; il 19 agosto 1935. Il podestà divise la strada in due
tratti : quella a mare divenne ‘via Martiri Fascisti‘ e quella a monte ‘via delle
Corporazioni’. Nel 1945 , per la legge del ‘chi vince ha diritto
all’ultima’ divennero rispettivamente ‘via P.Reti’
e ‘via W.Fillak’
DEDICATA al secondo re d’ Italia,
soprannominato“re buono”.
Umberto di Savoia nacque a
Torino il 14 mar.1844 da Vittorio Emanuele II e da Maria Adelaide d’Austria.
Da giovanotto, per ovvietà
sociale e forse anche per contrastare il naturale carattere mite ed incerto, fu
avviato alla carriera militare; a 22 anni partecipò con distinzione nella
perduta battaglia di Custoza (1866 - 3ª guerra di Indipendenza, fece parte del
famoso quadrato del 49° reggimento) ove si meritò una medaglia d’oro al VM.
Divenuto re per successione
nell’anno 1878, ebbe un periodo di governo assai difficile sia per le
difficoltà economiche legate a tutte le guerre affrontate sino ad allora; sia
per il contrasto con le forti forze repubblicane che –nella sua ottica- stavano
quiete solo nei periodo bellici a cui partecipavano in massa come volontari ma
che in pace innescavano irrequietudine nelle popolazioni sollevando gravi
problemi sociali; sia per le difficoltà burocratiche nell’amministrare
uniformemente tutte le terre unificate, legate come ideale ma con ciascuna
abitudini burocratiche ed amministrative diverse: quindi una Italia unita
politicamente e militarmente, ma non ancora nell’assetto ideologico e
produttivo; sia infine per delle scelte -a posteriori giudicabili inopportune
ed infruttuose, se non addirittura portatrici alla nazione solo di lutti e
difficoltà economiche- come la guerra d’Africa, la Triplice Alleanza, il
dissidio con la Francia. Quindi in sostanza ‘buono’ per modoi di dire e molto
di parte.
Sposò Margherita di Savoia,
nata a Torino e figlia del Duca di Genova;
la quale politicamente fu sempre
più legata alle destre (fino al fascismo) e che assai spesso riuscì ad
influenzare anche il consorte, costringendolo ad una personale condotta ‘cerchiobottista’.
Tipici esempi sono, per di qua, le scelte neo assolutiste, tipo decorare il
generale Fiorenzo Bava Beccaris (che aveva –poco
gloriosamente - soffocato nel sangue le rivolte della Lunigiana (1894) e di
Milano (1898, arrestando nelle patrie galere riformisti (Anna Kuliscioff e Filippo Turati), anarchici, cattolici progressisti (don Davide Albertario), socialisti e poeti schierati nella protesta (Pietro Gori, assente da Milano ma compositore di una
poesia contestatrice); oppure
tentare una svolta del regolamento parlamentare somigliante ad un colpo di stato
mirato a diminuire o annullare l’appena inaugurata svolta democratica (sorretto dai ministri Starabba march.di Rudinì e dal
gen. Pelloux, ma sventato dai liberali giolittiani, dai radicali e socialisti
(tra essi –in Parlamento- Leonida Bissolati, moderato, dopo essersi azzuffato
in aula di Montecitorio contro Sidney Sonnino e Prampolini, rovesciò nell’aula
l’urna della pericolosa votazione). Per di là, anche se ammansito da questa
pesante sconfitta elettorale, avallando infine - o meglio, politicamente costretto
- la svolta liberale giolittiana, riconoscendola nel successivo – e per lui
ultimo - discorso alla Camera (16 giu.1900) di inizio legislatura.
L’errore più grave fu di non
aver capito e quindi non aver affrontato il malumore e l’agitazione popolare;
illuso da lusinghe imperialiste e glorie esteriori, non prese decisioni per
arginare le gravi incrinature dovute ai dissidi sociali interni, che gli
causarono ben tre attentati alla vita, di cui l’ultimo fatale per mano
dell’anarchico Gaetano Bresci il 29 lug.1900 a Monza, ove era per una
premiazione scolastica.
Il
Bresci anarchico pratese, trentunenne, tessitore di seta, schedato come
sovversivo ha però la fedina penale pulita; venuto apposta da Paterson in
America e sistematosi momentaneamente dalla sorella presso Bologna dove
riusciva anche ad esercitarsi al tiro a segno con la pistola. Senza una
organizzazione più vasta, per propria iniziativa quindi, riuscì a saltare sul
predellino della carrozza ed a sparare a bruciapelo tre colpi (uno al cuore,
uno alla spalla, ed uno al polmone. Fu subito catturato; nel preparare il
processo chiese essere seguito a Filippo Turati che però rinunciò; fu difeso da
un altro anarchico avv.Francesco Saverio Merlino, non trovando nessuno che si
arrischiava a provare a difenderlo pubblicamente; difatti nemmeno poté sviluppare
la tesi difensiva quando il Presidente sbrigativamente interruppe l’arringa.
Ergastolo. Ma il 22 maggio dell’anno dopo, 1901, fu trovato morto in cella nel
penitenziario di santo Stefano, suicida per impiccagione o -per i suoi amici-
‘suicidato’. Emotivi di sospetto ce ne sono tanti, dall’uso giornaliero del ‘santantonio’
ovvero percosse a dosi quotidiane, all’abbandono anche dei suoi simpatizzanti
politici (che intravvedevano nel re le aperture a riforme di liberalizzazione,
all’assenza di qualsiasi documento nella cartella a lui intestata
dell’Archivio di Stato).
La salma fu tumulata a Roma,
nel Pantheon.
Alla sua morte, il successore
diede il via ad una serie di riforme in senso liberale e sociale (età giolittiana).
Nel 1898, il re aveva stipulato
una polizza vita con i Lloyd londinesi: la
famiglia non poté intascare la somma per vari motivi (tra i quali il
congelamento dei beni all’estero durante l’embargo -quando l’Italia invase
l’Etiopia-; e l’ultimo conflitto). La cifra più gli interessi (2 miliardi nel
1950) fu prelevata dai Savoia dopo un tentativo dell’avvocatura di Stato della
Repubblica di rivendicarne la riscossione.
BIBLIOGRAFIA
-Alizeri F.-guida illustrativa
per la città di Ge.-Sambolino.1875-pag.667
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4525
-A.sconosciuto-Storia del
trasporto pubblico a Ge.-Sagep.1980-pag.204
-Ciliento B-Gli scozzesi in
piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.55.56.92
-Cevini-Torre-Architettura e
industria-Sagep.1994-pag.117
-DeLandolina
GC–Sampierdarena-Rinascenza .1922 – pag. 57
-Doria M.-Sampierdarena 1864-1914
mutualismo e...-Ames.2005-p.66
-Enciclopedia Motta
-Enciclopedia Sonzoagno
-Gazzettino Sampierdarenese :
7/80.7 +
-Genova Rivista municipale
6/32. + 2/33.121.209 + 7/33.5 +
-Il Secolo XIX del 29
luglio2000.pag. 24 +
-Lamponi M-Valpolcevera come
eravamo-Mondani.1993-pag.2
-Naniglio.Calcagno-Giardini,
parchi e paesaggi...-Sagep.1991-67-80
-Novella P.-Strade di Genova-
Manoscritto b.Berio.1900-pag.14.19
-Pagano/1908-pag.873-9—-/19-pag.1015-—/33-pag.1690-7---/61-pag.444
-Pastorino.Vigliero-Dizionario
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1793
-Pescio A.I nomi delle strade di
Genova-Forni.1986-pag.350
-Quaini M.-Carte cartografi in
Liguria-Sagep.1986-pag.57
-Stradario Comune di Genova
–edizione 1953-pag.-59.77
-
UNIONE vico
(dell’ ) Unione
Ora si chiama vico P.M.Ciurlo (nella
targa stradale, in basso a sinistra è registrato:”già vico dell’Unione”);
ed è una traversale di congiunzione tra via
della Cella e via G.Giovanetti .
Evidentemente fu scelto in
onore alle numerose Società di Mutuo Soccorso e cooperative che si
organizzarono nel borgo e poi nella piccola città, per mettere in pratica
quella parte dei dettami mazziniani, di solidarietà, fratellanza ed unione.
Fu così chiamato negli anni
attorno al 1850 quando una delibera comunale approvò di dare nome ad alcune
strade, tra cui questa; e sarà poi confermata, nel regio decreto del 1857 ove
compare esistente ed ufficialmente riconosciuta.
Nel 1901 risulta vi
abitassero al civ. 1 Sala Pasquale e C; al civ.2 eredi Lavino e Carrozzini; al
civ. 3 Vernazza.
Nell’elenco delle strade
comunali, pubblicato nel 1910, compare ‘vico dell’Unione, da via Cella a via
A.Doria’ con un unico civico.
Nel 1926, solo due centri possedevano una titolazione
eguale: SPd’Arena con il vicolo, e Voltri con una piazza
Il nostro ancora era con questo nome nel 1933, di 5.a
categoria, con civici sino all’ 1 e 4 .
Fu il podestà che il 19
agosto 1935 deliberò cambiare il nome; non si conosce con quale logica o tipo
di scelta fu preferito Voltri o forse, fu eliminato in ambedue perché scomparve
definitivamente dalla toponomastica cittadina.
In alcuni testi è senza, in
alcuni con la scritta “dell’ “.
Nell’elenco comunale è senza la
particella.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-Archivio Storico Comunale
Toponomastica - scheda 4530
-DeLandolina GC.-Sampierdarena
-Rinascenza.1922 – pag. 57
-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19
-Pagano/1933-pag.249
UZIEL vico Enrico Uziel
TARGHE:
vico – Enrico Uziel –
patriota dei Mille – 1842-1860 – già vico Maddaloni
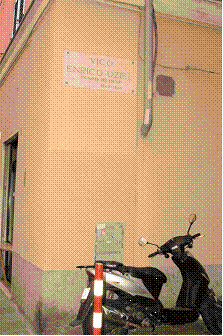


in angolo
con via della Cella
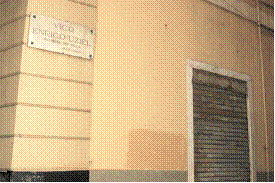

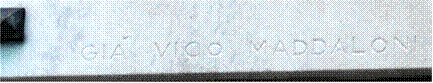
in angolo
con via G.Giovanetti
QUARTIERE
ANTICO: Castello
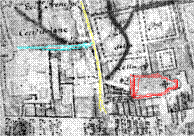 da MVinzoni, 1757. In rosso la
chiesa della Cella; giallo, via della Cella, celeste ipotetico tracciato di via
BGhiglione.
da MVinzoni, 1757. In rosso la
chiesa della Cella; giallo, via della Cella, celeste ipotetico tracciato di via
BGhiglione.
N° IMMATRICOLAZIONE:
2859 Categoria: 3
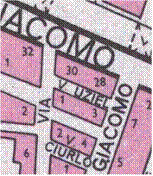 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8
CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 63000
UNITÀ URBANISTICA: 26
– SAMPIERDARENA
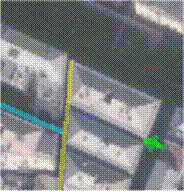 da Google Earth, 2007. in celeste
via BGhiglione; giallo, via della Cella; la freccia verde indica il vicolo.
da Google Earth, 2007. in celeste
via BGhiglione; giallo, via della Cella; la freccia verde indica il vicolo.
CAP: 16149
PARROCCHIA: N.S.
della Cella
STRUTTURA: collega
via della Cella (inferiore), con via G.Giovanetti: teoricamente è doppio senso
veicolare non essendoci divieti, ma in pratica è agibile solo da motocicli
essendo impossibile per le auto voltare dalla parte di via della Cella.
Strada comunale carrabile, lunga 32 metri e larga 3, senza marciapiedi.
CIVICI:
2007=
NERI = da 1 a 3
ROSSI = da 1r a 3r e
da 2r a 10r
Nel
Pagano/40 è strada che – come oggi - va da via G.Giovanetti a via della Cella e
sono sono segnalati i civv. 1 e 3.
STORIA: con
l’erezione delle case e la delimitazione della stradina, il primo nome
ufficiale fu di “vico Maddaloni” (vedi),
di 5.a categoria e quando via Giovanetti ancora si chiamava via A.Doria . E tale rimase sino alla famosa data del 19 agosto
1935, quando il podestà di Genova firmò il cambio col nome attuale.
DEDICATA al genovese
di adozione, essendo nato a Aronne (Venezia) il 13 ott.1842. La famiglia,
fuggiasca quando lui aveva sette anni, col padre esiliato dopo una perduta
rivolta in città, raggiunse Genova ove crebbe coltivando gli ideali
dell’indipendenza. Due
cugini, Giuseppe e Davide, anch’essi rifugiati a Genova, più maturi d’età
divennero Cacciatori delle Alpi combattendo nel 1859 la seconda guerra di
Indipendenza. Ma appena anche lui ebbe
raggiunta l’età di diciotto anni, volle partecipare: seppur con non semplici
difficoltà, si propose per la spedizione dei Mille. Aiutato dalla soc.di Mutuo Soccorso,
fu incaricato di coordinare i volontari che arrivavano da più regioni; allo
scopo su un manoscritto autografo di tre fogli (conservati al Museo del
Risorgimento), scrisse le “istruzioni per la radunanza e l’itinerario di coloro
che prendono parte alla spedizione di Sicilia per raggiungere il punto di
partenza“; minuziose le raccomandazioni per passare inosservati alla polizia
sabauda. La polizia,
su istruzioni di Cavour sorvegliava la zona, ma “lasciava fare” purché non si
creassero sul momento complicazioni che potessero portare a problemi
diplomatici; era ben a conoscenza che molte confederazioni operaie, da tempo
lavoravano di nascosto per contribuire alla missione, e che i due vapori
-Piemonte e Lombardo- non erano là per caso ma pronti per la partenza per
disposizioni accordate tra Bixio e G.B.Fauché (dipendente del proprietario
Raffaele Rubattino; le navi sarebbero state da arrembare con l’inganno ed il
proprietario era ben consapevole che sarebbero andate perdute).
Facendo
parte degli esperti nel tiro con la carabina, riuscì a partire con questo corpo
(dei carabinieri), comandato da Antonio Mosto, costituiva un reparto a sé pur essendo di solo
trentadue persone; questi , armati di carabina, erano i migliori tiratori
scelti tra i tanti che andavano ad esercitarsi sui campi di tiro cittadini.
Costituirono l’arma vincente per i garibaldini: ben appostati, seppur a
discreta distanza, formavano ampi vuoti nelle file dei soldati borbonici ancor
comandati a marciare affiancati a ranghi serrati per essere pronti a far
quadrato, ma altrettanto così ravvicinati che ad ogni colpo ne cadeva
matematicamente uno.
Ebbe il battesimo di fuoco appena sbarcato, e combatté eroicamente a
Calatafimi, e via via fino a Palermo.
In questa città, il 27 mag.1870, il giovane appena diciottenne, mentre
scambiava battaglia con soldati borbonici appostati nei pressi del palazzo
Reale, venne colpito da un proiettile di cannone, rimanendo ucciso con la gola
recisa. Questa
battaglia durò tre giorni: i Mille affiancati da pochi volontari locali, e da
alcuni cittadini insorti, tennero testa a 18mila borbonici, combattendo per le
strade barricate e sotto il cieco bombardamento delle navi del re. Il momento
drammatico si raggiunse quando truppe fresche borboniche erano sul rientro in
città dopo essere state distolte da un fasullo inseguimento creato da Garibaldi
con ingannevole diversivo: ma fortuna volle che in contemporanea il generale
borbonico Lanza, non consapevole né delle sue forze né della precarietà dei
garibaldini, ma anzi preoccupato per la tenacia degli insorti e per i troppi
feriti e morti tra i suoi, chiese la resa.
Le
sue spoglie mortali andarono confuse con quelle degli altri caduti
nell’offensiva di Palermo.
Il cugino Giuseppe Uziel, comandante della 1.a compagnia
del battaglione dei volontari genovesi, cadde gravemente ferito al petto a
Monterotondo, morendo dopo pochi giorni.
A Genova, in via
G.Alessi 5, una targa muraria ricorda il cugino David.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio
Storico Comunale Toponomastica - scheda 4537
-AA.VV.-Annuario.guida
archidiocesi—ed./94-pag.451---ed./02-pag.487
-Codignola
A-Genova e l’imprea dei 1000-Canesi 1961-I-pag. 338.340
-Genova
rivista municipale : 12/1937.37ritratto
-Milani
M.-Garibaldi e i 1000-Igiemme 1960-
-Morabito
Costa-Universo della solidarietà-priamari.1995-pag.170
-Lamponi
M-Sampierdarena- LibroPiù.2002-pag.90
-Novella
P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.18
-Pagano
ed.1933-pag.70- ; ed.1961-pag.417
-Pastorino.Vigliero-Dizion.
delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1795fot
non
citato da Enciclopedia Sonzogno e Motta

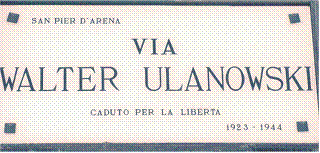
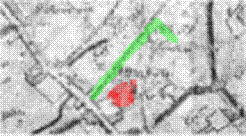 da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con
rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).
da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con
rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).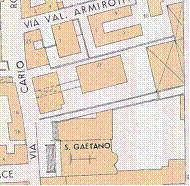
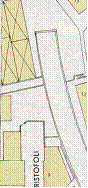 da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada
ancora non esisteva.
da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada
ancora non esisteva. da Google Earth, 2007
da Google Earth, 2007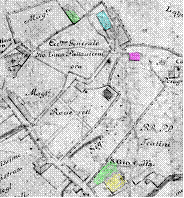 La loro villa invece, in una carta
del 1891 (nel libro di
don Bosco) appare
all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,
corrisponde (in viola –
non sono sicuro -)–per
posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà
dei sig.ri Ghezzi la
cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una
strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle
spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene
attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere
quella
La loro villa invece, in una carta
del 1891 (nel libro di
don Bosco) appare
all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,
corrisponde (in viola –
non sono sicuro -)–per
posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà
dei sig.ri Ghezzi la
cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una
strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle
spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene
attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere
quella 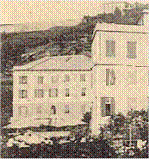
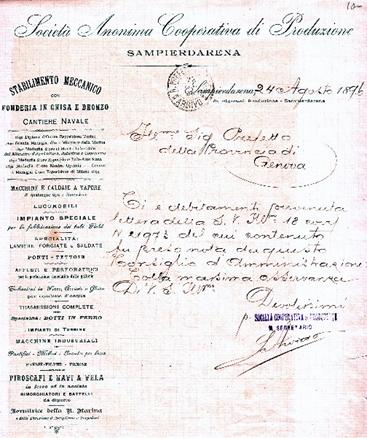
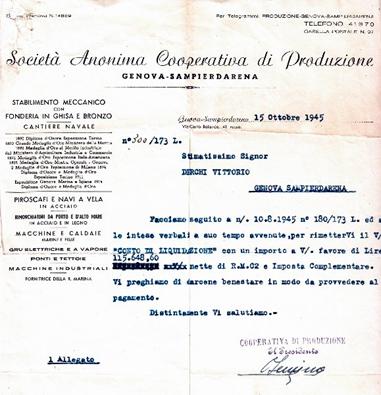
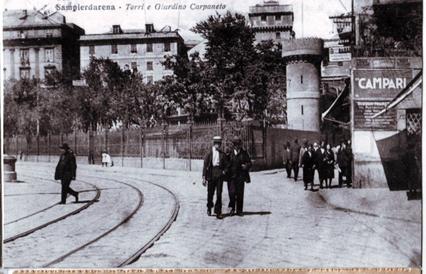
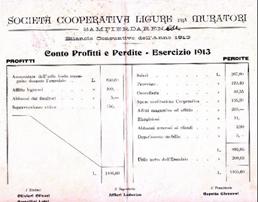
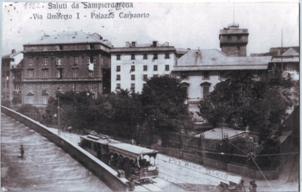

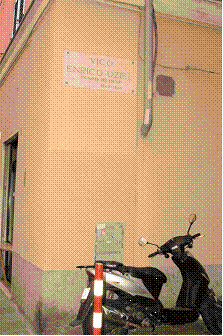


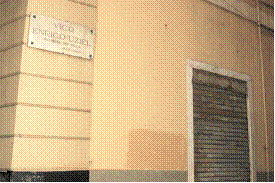

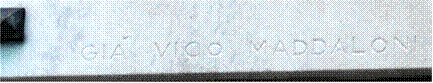
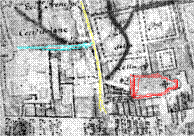
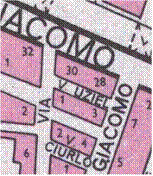 da
Pagano 1967-8
da
Pagano 1967-8