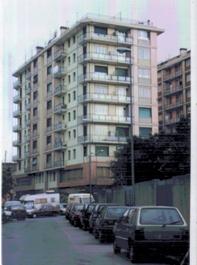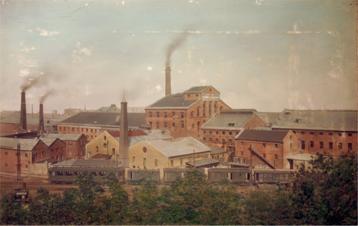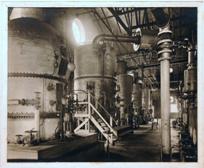CIVICI
Nel 2007, continuità unica
senza colore: da 1 a 25 e da 2 a 68
Oltre alle case per
abitazione, sono sorti molti uffici e magazzini, commercianti,
autotrasportatori e depositi.
===civ.3 la Società sportiva
Crocera, con il Crocera stadium nata
subito dopo la ristrutturazione (ma a mio avviso, la Piscina ed il complesso sportivo
comunale chiamati ‘la Crociera’, sono in via T.Grossi).
===civv. 7 e 8: eretti nel 1965 ; il 52 nel 1969.
===civ. 52, una sede secondaria dei Carabinieri.
STORIA: zona: nella carta vinzoniana del 1757 vedila sopra; descrivendola procedendo verso
ponente, la possiamo immaginare alla fine occidentale della proprietà di
Domenico Spinola (la cui villa si apriva in via C.Rolando, sostituita dalle
scuole ma con ancora conservata la torre)
la zona appare compresa tra le terre dell’ecc.mo e mag.ci fratelli Venerosi (con sulla strada una grossa casa
intestata al r.do Ambroggi(o)...(illeggibile), e con la stretta striscia -prima del torrente-
di proprietà del sig. Gio Batta Grondona (con sulla strada un molino alimentato da un ramo del
torrente deviato verso levante all’altezza dell’abbazia di sanMartino).
Una
altra carta, presumo del Porro del 1781, evidenzia la strada principale
al ponte ovviamente anonima. A nord di essa, - ed in senso inverso, a levante
del torrente - terreni di proprietà del ‘sig. GB Grondona ora Cambiaso’
confinante con il terreno dei ‘fratelli Veneruso’ (sulla strada la villa, sicuramente
quella presente sino a poche decine di anni fa all’inizio di via Pieragostini) seguiti sempre verso est dalle terre dell’ecc.mo
Domenico Spinola (nella
parte più a ponente dei quali sono tracciate due ipotesi della attuale via
Spataro, essendo una di esse vicino alla villa di cui sopra).
Sino
al 1800, era una zona periferica, genericamente disabitata, fors’anche
per le bizzarrie del torrente allora ancora libero, non ben incanalato e quindi
allargato rispetto oggi; in quell’epoca esistevano in zona dei mulini per i quali
erano stati aperti dei canali appositi che si alimentavano d’acqua
distaccandosi dal torrente a livello del Campasso. Non zona insalubre, per il
vento; ma non certo da villeggiatura.
E
sappiamo che nel 1820 in una casa eretta in questa zona anche se prospiciente
una via san Cristoforo oggi non più
esistente, nacque don Nicolò Daste.
A
Genova, meglio a San Pier d’Arena una prima fabbrica
di zucchero, ma di proporzioni artigianali per prima, negli anni
vicini al 1811, era stata aperta da Lorenzo Dufour nella zona del Canto, ma non nei pressi di questa strada ma
nell’angolo a ponente dove ora da via Sampierdarena iniziano via Antica Fiumara
(vedi) e via Pacinotti: la grandiosa ‘Villa del Vento’ da tempo abbandonata e
che Lorenzo dopo averla comprata le rifece il tetto, intonacati i muri, divisa
l’altezza in piani più bassi usando come travi vecchi alberi di bastimenti,
ripristinando anche la torre posta sull’angolo. Ebbe vita breve, sia per
inesperienza degli iniziatori, sia per gli avvenimenti politici seguenti alla
sconfitta di Napoleone con il ricupero del mercato da parte degli inglesi, sia
per problemi doganali di non protezione.
Ma fu nel 1872 in piena era dell’industrializzazione, che si aprì
direttamente in via san Cristoforo civ.27 perché verso la linea ferroviaria,
separati
da una strada, oggi via G.Spataro, da un vasto terreno che sarà edificato dal regio demanio per i tabacchi.
Lo
zuccherificio, nacque ufficialmente il 9 feb.1872 col nome di “raffineria zuccheri soc.an.
Ligure Lombarda” (o diversamente “società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli
Zuccheri”. Il nome deriva dall’assorbimento della ‘Società Italiana per la
Raffineria degli Zuccheri’ nella ‘Ligure Lombarda’ che era la più vecchia
società genovese del settore. Sul Pagano/1902 è chiamata “(Raffinat. Zuccheri)
Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri, argini della Polcevera.
Telefono n. 824” ), con capitali di banche ed
imprenditori liguri.

Ebbe inizio impiegando da subito una maestranza di 400
operai (divenuti più di mille, vent’anni dopo), ed un giro di
affari di 40milioni/anno (utili nettamente superiori alla
media della altre società del settore): vi avveniva la raffinazione del
materiale grezzo (barbabietole) trasportato per ferrovia dall’Austria-Germania,
via Verona (minore la quantità di prodotto proveniente dalla canna da zucchero
di oltre oceano, pervenuto grezzo via nave), e rivenduto raffinato con
riutilizzo dei residui (specie la melassa) e dei sottoprodotti. Agli inizi e per oltre un lustro, malgrado il
capitale lentamente aumentasse, non ci furono utili da spartirsi e
minacciosamente nel 1876 si chiusero
alcuni reparti (la distilleria del melasso) perché i trattati commerciali favorivano l’importazione dalle industrie
straniere.
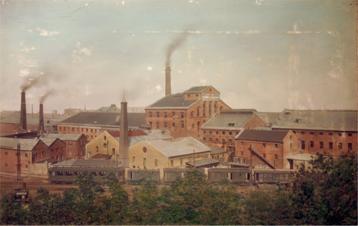


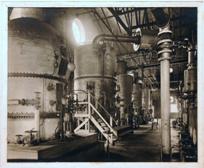

L’insieme (o meglio i
4/5 del capitale sociale) fu presto ceduto ad un gruppo lombardo con a capo la
società milanese Ercole Erba, che prevedendone i benefici, nel
regno si era reso unico proprietario del più moderno sistema di raffinazione,
dal suo inventore detto ‘Schröder’: ne cedette l’uso in cambio delle azioni (il capitale sociale era di 15 milioni di lire, diviso in
20mila azioni da 250 lire cad. (5, dice Doria)) per le quali comunque il 25% degli utili rimaneva all’industriale
milanese, lasciando il resto per la costruzione e completamento dell’impianto. Di genovesi a noi conosciuti, rimanevano azionisti Giovanni Bombrini,
Domenico Balduino, il marchese Giacomo Balbi (?).
Nel 1879, l’azienda finalmente privilegiata da
manovre daziarie a carico degli importatori del prodotto ed indirizzate a
rivalutare l’attività industriale italiana
(innalzamento del dazio
del 65% e conseguente ricupero di tutti i dividendi passati, in ragione di un
interesse del 6%; nel 1881 i profitti saranno pari al 27% del capitale con
dividendi superiori al 18% del valore delle azioni), riuscì a decollare ed a rimanere in quota indisturbata, anzi anche ad
ingrandirsi (sia aprendo nel 1881 una nuova
raffineria a sanMartino Buonalbergo di Verona, sia assorbendo nel 1888 la già
importante e ben solida sul mercato “Società Italiana Zuccheri”. Nel 1881 ben
71 erano gli azionisti, con i lombardi a costituire oltre un terzo del capitale
e dei genovesi i soliti Giovanni Bombrini, M.Casaretto, Domenico Balduino,
P.Pastorino, il marchese Giacomo Balbi ed altri tra cui tre banche).
In
contemporanea, favoriti dal clima favorevole delle nuove leggi, a San Pier
d’Arena – ma non specificato dove - si aprì un secondo opificio “laboratorio per zuccheri di ‘Novaro & Arrigoni’“
che ovviamente ebbe vita breve considerato la concorrenza del grosso
complesso, che non concesse spazi commerciali.



Nello
stesso anno, il 4 agosto (l’anno dopo essere divenuto re) lo stabilimento fu
visitato da UmbertoI durante un soggiorno nella città di Genova. Fu apposta, ed
ancora c’è nell’entrata, una specie di targa (scritta su un rilievo di cemento,
come se fosse di marmo: UMBERTO
I – RE D’ITALIA – E IL
PRINCIPE AMEDEO DUCA D’AOSTA – VISITAVANO QUESTO
OPIFICIO – IL GIORNO IV AGOSTO MDCCCLXXIX***).
Lamponi ricorda riferendolo al 1892, il
curioso episodio del re che chiese al direttore se le ciminiere che eruttavano
fumo erano state messe in regola con le leggi vigenti, ottenendo
tranquillizzazione in proposito.
Nel 1882 la società aprì una terza raffineria a Sinigallia,
ed acquistò dai francesi un nuovo brevetto di raffinazione; questo permise sia
di raffinare il prodotto in 36 ore anziché -come prima- in 20 giorni, sia di
rendere il prodotto tra i più appetibili e di alta soddisfazione degli
acquirenti. Questo salto di qualità, a sua volta permise far divenire lo
stabilimento -con prevedibili alti e bassi-, il più importante centro di
produzione dello zucchero nazionale, ponendo accordi di vendita con le altre
industrie (per prima, quella di Rivarolo).
Affiancato, era lo jutificio, addetto alla tessitura dei
sacchi, usati per il trasporto del materiale, sia importato che lavorato.
Lunedi 27 feb.1899 a Genova in via Ponte Reale 5 dodici tra
banchieri, industriali e commercianti (più una interessenza tedesca interessata
prevalentemente all’industria della juta)
si riunirono per dar vita, regnando Umberto I, alla “soc.Eridania”
terza fabbrica di Zucchero” (Eridano è un
antico nome del Po; per altri è invece il Rodano: perché narrava la leggenda
greca per la quale Eridano – nato da Teti ed Oceano, era posizionato nel
‘lontano nord ovest’; e nel quale vi precipitò Fetonte figlio del Sole e di
Climene: volendo guidare il carro del sole, si avvicinò troppoa alla terra,
minacciando di incendiarla; il padre lo fulminò e lo fece precipitare nel
fiume. Le sorelle, piangendolo furono trasformate in pioppi. È pure una
costellazione australe) con lo scopo di impiantare ed esercire (sic) delle fabbriche capaci di produrre zucchero e poi commerciarlo (capitale 2milioni e mezzo, in azioni da 100 lire cadauna, per la durata
di 30 anni; poi invece aumentato a 4milioni l’anno dopo). Con centro direzionale in città, due le fabbriche nate in l’Italia
(Codigoro e Forlì), ebbe alterne ma nell’insieme positive e sempre maggiori
capacità di qualità manifatturiale e di potere industriale, sia con lo
sfruttamento locale della barbabietola, sia per alte capacità manageriali in un
‘travolgente’ avanzare del capitale genovese nell’industria (soprattutto alimentare ma anche fuori del settore tipo
investendo,1905-7, cospicui capitali anche in altre aziende tipo la Eternit,
la Ligure Calce e cemento e la Ollomont ramifera a Piacenza).
Dialogando con la vicina Ligure Lombarda nel 1901 si stipulano accordi che consentono
acquistare un terzo stabilimento a Cecina e di aumentare il valore degli
impianti senza variare il capitale. Nel 1904
agli azionisti viene chiarito che l’Eridania non
sarà solo una fabbrica di zuccheri ma una ‘società industriale’ cioè apertura a
360 gradi di speculazione con interventi finanziari; cosicché dai 4milioni
iniziali del 1901 si arriva in sette anni a poco meno di 26milioni di capitale controllando i pacchetti di 9
società nel ramo saccarifero, una banca (Banco di Liguria), una fabbrica di
birra (Cervisia), 2 imprese tessili (uno iutificio a LaSpezia ed il Cotonificio
Ligure), e soc. di materiale edile (Eternit e Plinthos), una impresa
siderurgica (Acciaierie e Ferriere di Prà)i, una impresa mineraria (Ollomont,
di rame) il tutto con ovvie ramificazioni successive. I vari amministratori e principali azionisti, siedono su molteplici
poltrone direttive (Giacomo Becchi, GB Figari (probabilmente lui il proprietario di una fabbrica di
colla e sego posta allo sbocco del torrente, dalle cui ciminiere usciva un
lezzo tale che faceva dire alla gente che bruciavano asini), G.Falcone, R.Grondona, P.Ravano,
F.Romanengo) intrecciati con reciproche cointeressenze di uomini e capitali,
creando la holding delle società del ramo.
É in questi anni che l’azienda fu vittima di un grave e
vistoso incendio, che distrusse vari reparti; sconvolti gli operai addetti,
preoccupati della perdita del lavoro quando nulla garantiva la continuità dello
stipendio in casi simili.
La febbre speculativa portò nel 1907
l’inizio di una crisi nazionale delle industrie italiane in quasi tutti i
settori, con cedimenti e chiusura delle industrie più deboli e comunque
diminuzione del valore degli impianti. Quattro aziende nate in quegli anni nel
settore saccarifero, vennero così travolte e costrette al fallimento dalla
coalizione del grande trust al quale l’Eridania era a capo; questo permise di
superare il lustro con basse perdite (-10% il valore degli impianti, -5% quello
delle partecipazioni). Il Pagano/08
riporta, della azienda a Sampierdarena, la raffineria di zucchero, lo iutificio
e la distilleria alcool (la
direzione era in piazza della Zecca nel palazzo ex Centurione).
Nell’ anno 1930
avvennero cambiamenti sostanziali nell’industria saccarifera italiana: la
società Eridania (già allargatasi e potenziatasi
incorporando altre società), si fuse con un altro grosso
complesso genovese: gli “Zuccherifici Nazionali”(che nel
frattempo stava assorbendo la soc. Ligure Lombarda): il 23 nov.1930 nacque la nuova “Eridania Zuccherifici Nazionali”, competitiva sul
mercato possedendo 21 zuccherifici oltre a raffinerie, distillerie e fabbriche
di lievito, mannite, acido lattico, etere e juta. In contemporanea, la sede
amministrativa generale fu trasferita da via Caffaro in corso A.Podestà (già sede dal 1913 della soc.Ligure Lombarda) .
Nel 1934 lo stabilimento di San Pier d’Arena
sperimentò per primo la ‘cassa di quiescenza’, istituzione con la quale i
pensionandi potevano raddoppiare tramite assegno integrativo il magro sussidio
erogato dalla Previdenza Sociale.
All’inizio dell’evento
bellico del 1940, la società era in condizioni
finanziarie e commerciali assai solide e floride, con ideale equilibrio tra
l’attività agricola, la produzione industriale, e l’uso del prodotto. La guerra
creò immensi problemi, di fornitura, approvvigionamenti, e distribuzione;
distruzioni, disorganizzazione e saccheggiamenti, che furono superati con la
Liberazione (Sampierdarena ebbe la fabbrica
relativamente danneggiata, ma nel 1946 era di nuovo in piena attività). Genova sempre conservava la direzione amministrativa, mentre
nell’ambito societario lo stabilimento sampierdarenese -nato per primo nel
1872- era al primo posto come raffineria
(con produzione minore
anche di distilleria, e fabbrica di lievito)
con una potenzialità di
3000 (=quintali giornalieri di raffinato prodotto ; rispetto ai 2000 di
Pontelagoscuro).
E’ mio ricordo personale in questi anni –ma non so quando
iniziò ad essere in uso- il colore della carta dei pacchetti in vendita di
zucchero: un blu diverso dagli altri, e pertanto definito ‘blu zucchero’, che
fu copiato poi anche dai fabbricanti di tessuti.
All’inizio degli anni
cinquanta, il complesso industriale, in pieno benessere produttivo e sanità
economica, era degli industriali saccariferi Cevasco (che aveva la maggioranza; ma morì precocemente lasciando eredi le due
figlie che affidarono la parte a Domenico Borasio: una specie di factotum operativo) & Bertollo; Benedetto Acquarone era presidente.
Amministratore delegato fu nominato da Borasio il pf. DeAndré (prof. di filosofia; soggetto di straordinaria capacità di apprendere
ed applicare, seppur di carattere tendenzialmente duro, inflessibile, spigoloso: vero terrore dei dirigenti; ma
efficentissimo; un figlio –Fabrizio- è stato il
famoso cantautore ‘Faber’; l’altro, avvocato. Dopo Eridania, divenne presidente
della Fiera).
Negli anni, il complesso passò alla guida del finanziere
milanese Aldo Ravelli, che a sua volta lo cedette al petroliere Attilio
Monti, fino agli ultimi anni settanta quando lo acquisì il ravennate gruppo
Serafino Ferruzzi (gestito diligentemente dal dirigente
dr Renato Picco e partecipi del nuovo consiglio di amministrazione Raul
Gardini, l’avv Mauro DeAndré, Rieffeser (marito di una Ferruzzi)).
L’attività produttiva
trovò difficoltà quando entrò in crisi la Ferruzzi, e col suicidio di Gardini;
effetto tale, che nel 1970 portò i dirigenti a fondersi con la Béguin (o
Béghin)-Say (la più importante francese del
settore; seppur mantenendo la quota di maggioranza; e mettendosi in vicinanza
con il settore inglese che possiede le strutture più efficienti d’Europa).
Ma con l’abbandono e
disimpegno di grandi famiglie azioniste cominciò il declino dell’ IIZ
(Industria Italiana Zuccheri) che passò al gruppo Montesi di Padova il
cui dissesto all’inizio degli anni ottanta, fece perdere identità alla società.
In
queste fasi, fu deciso trasferire la attività dello stabilimento in altra sede
e chiudere definitivamente l’opificio di San Pier d’Arena (mentre a Genova veniva conservata
-nello storico palazzo di corso Andrea Podestà, civ.2- la sede del centro
direzionale e di governo societario, impegnato nelle strategie di mercato e di
espansione, anche se il capitale di controllo non era più in città.
Divenne così oggetto di frequente cronaca cittadina, la
alternanza se si o no, l’Eridania a Genova (intendendo la ormai sola
direzione; e, per essa, un patrimonio storico, in quanto divenuto il più
importante gruppo agro-industriale europeo). Nel 1997 il presidente della
società Beghin Say già minacciava trasferire tutto a Ferrara: cosa avvenuta a
fine 1999 (dopo esatti 100 anni di vita: prima capitali liguri, poi finanze del
milanese Ravelli, del petroliere Attilio Monti, e dal 1970 del gruppo Ferruzzi)
ed il suo vice, Giuseppe DeAndré –padre del cantautore Fabrizio- che volevano
una sede adeguata alle loro nuove esigenze, magari un grattacielo di 33 piani;
il che trovava enormi difficoltà urbanistiche e dopo interminabili tira e molla
non nascerà mai, con rabbia della dirigenza e decisione finale dell’abbandono
della città. Il palazzo, fu venduto poi all’Università nel 2001).
L’area divenne sede di progetti tra l’azienda stessa ed il comune, e fonte di
estenuanti trattative; vinsero i costruttori: i grossi edifici più a mare
furono demoliti totalmente, e già nel 1965 si offriva la possibilità di
insediarsi nei nuovi condomini, attualmente collocati ai lati della strada,
nata ex novo per l’accesso residenziale, e dall’amministrazione comunale dedicata alla grossa
industria (che - assieme ad altri pesanti
“traslochi” di altre grosse imprese (Esso, Mobil, Italcantieri, Mira Lanza, la flotta di stato,
la IP, Dufour, ecc) diede un ulteriore grosso colpo di
mannaia sulla fama imprenditoriale di Genova e sulla sua capacità occupazionale).
L’assegnazione del nome stradale, fu deliberata dal consiglio comunale il 7
giu.1965.
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 1702
-AA.VV.-Annuario.guida archidiocesi-ed./1994-pag.403—ed./02-pag.440
-AA.VV.-90anni con il Lavoro-Basile.1993-pag.36foto +
-Doria G.-Investimenti e sviluppo econ. a
Ge.-Giuffré.1969-vol.I-pag.326
-
.1973-vol.II-pag755
-“Eridania” Zuccherifici Nazionali-Storia di 50anni-1949
-Enciclopedia Sonzogno-vol.II-pag.1818
-Favretto G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo
e...-Ames.2005-p.169
-Gardella PL.-Prime esperienze di industria
saccarifera-Microstorie,II-p.36
-Gazzettino Sampierdarenese : 5/75.1 +
-Lamponi M.-Sampierdarena. LibroPiù.2002-pag.120.
-L’Illustrazione italiana-n°3 del 20.01.1918-pag. 75
-Il
SecoloXIX : 23/5/98 + 26/9/01pag.22
-Manzitti
G.-Tempo di ricordare-DeFerrari.1999-pag.139
-Pagano/1933-pag.1688
-Puncuh
D.-Storia di Genova- .2003-pag.569
-Regina,
lunario genovese del signor R.-1889-pag.540
-Tuvo
T-Memorie storiche di SanPierd’Arena-Dattiloscr.inedito-pag.150
-Tuvo&Campagnol-Storia
di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.206
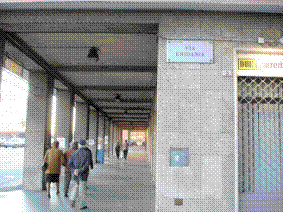
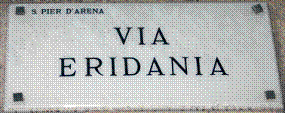

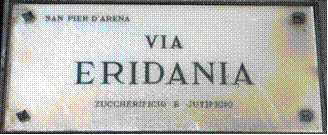
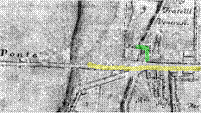 da MVinzoni, 1757 . In giallo via RPieragostini; in verde
ipotetico tracciato della strada nella proprietà che era allora dei mag.ci
fratelli Veneroso.
da MVinzoni, 1757 . In giallo via RPieragostini; in verde
ipotetico tracciato della strada nella proprietà che era allora dei mag.ci
fratelli Veneroso.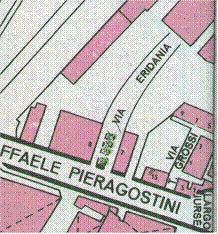
 da Google Earth 2007. In giallo via TGrossi.
da Google Earth 2007. In giallo via TGrossi.