DISPERATI vico Disperati
(DISPERSI vico Dispersi )
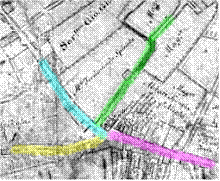 da Vinzoni, 1757 in fucsia via
NDaste; in giallo via A.Scaniglia; in celeste via CRolando.
da Vinzoni, 1757 in fucsia via
NDaste; in giallo via A.Scaniglia; in celeste via CRolando.
Il nome è citato nel libro ‘Storia di Sampierdarena” di Tuvo, a delimitazione dei Quartieri dell’Eguaglianza e della Fratellanza, secondo un decreto del 24 lug.1798 da parte del nuovo governo filofrancese della Repubblica Ligure, mirante a ristabilire l’ordine pubblico e la tranquillità in quegli anni di grave confusione politica. Così fu decisa la divisione del borgo in tre quartieri, genericamente con eguale proporzione di abitanti, dando ad essi nomi nuovi, ma usando limiti territoriali vecchi e preesistenti: l’ Eguaglianza era dalla via della Pietra al vico dei Buoi (a mare) e vico dei Disperati (a monte); a levante era il secondo quartiere della Fratellanza, sino a vico sant’Antonino (a mare; si sottolinea la confusione tra s.Antonio e s.Antonino)-vico san Barborino (a monte); il terzo, posto all’estremo levante dalla Coscia , era il quartiere della Libertà.
Alla fine dell’anno 1801, in epoca di dovuta convivenza con i soldati francesi, il concittadino Gaetano Bignone, per motivi non conosciuti chiuse arbitrariamente l’inizio della crosa, ponendovi un ‘rastello’ (cancello in ferro o in legno) che la municipalità gli impose di rimuovere essendo essa di spettanza pubblica.”Se l’ordine non verrà eseguito si farà eseguire l’atterramento”.
Il vicolo è confermato in un elenco delle strade esistenti il 29 maggio 1817 (firmato dal neosindaco Mongiardino Antonio): “inizia dalla strada provinciale, finisce nell’ultima villa vicino a Belvedere” (ovvero l’attuale via GB Monti; e la villa –ora abbattuta- era dove attualmente è il civ. 20).
In una ‘statistica dei cholerosi, morti a domicilio nel 1867’, stilato ad uso del Comune di San Pier d’Arena, si annovera un caso, avvenuto nella via, quindi ufficialmente riconosciuta.
Anche in una lettera, con cui la Curia Vescovile scrisse la sua approvazione all’erezione della nuova parrocchia di san Gaetano –che sino ad allora era stata prima chiesa privata, poi sconsacrata ed infine acquistata da don Bosco, e per i suoi fini riattivata, abbellita, resa funzionale e pubblica ma non ancora con l’incarico specifico parrocchiale-: in data 20 mar.1884 , si leggono i confini; ed oltre a strade conosciute, viene citato il “Vico Disperati“.
Una cartina del 1899 evidenzia la stradina “vico dei Disperati”, in corrispondenza delle attuali via C.Dattilo (che poi fu allargata)-E.Rayper fino a via G.B.Monti. Iniziante dunque in via Mercato (poi -già nell’anno 1900 da via A.Saffi), subito dietro la villa Carpaneto, con all’angolo la casa Ferrando (citata anche nel regio decreto del 22 magg.1857 con cui re Vittorio Emanuele II accettò la delibera comunale di San Pier d’Arena per la nomenclatura delle strade, in base a cui ‘via del Mercato’ dalla crosa della Cella arrivava fino ’alla casa Ferrando all’incrocio con via san Cristoforo’) e, per tutto il percorso, la proprietà Rebora-Cristofani a nord, ed orti a levante.
Arrivava in ripida diritta ascesa, e con un tornante alla fine, a levante della villa Lomellini Bocci (vedi via GB Monti, 20; per pura ipotesi, forse trasformata in lazzaretto). Forse finiva a quel livello ma da carte posteriori sembrerebbe che continuasse in salita -anche dopo il taglio effettuato dalla neonata via GBMonti- proseguendo in scaliata Pisacane (poi Filangieri) fino al tornante superiore della stessa via GB.Monti.
Lo stesso autore Tuvo, sul Gazzettino S., dà interpretazione del nome risalente forse ad una epidemia di colera durata due anni, e durante la quale la popolazione ebbe un calo del 60% con ovvia disperazione dei salvati che avevano cercato rifugio a monte del borgo nella speranza di essere in zona isolata ed al riparo dal cataclisma (se l’ipotesi dell’epidemia è giusta quale causa del nome, segnaliamo che la più grande strage o il più luttuoso avvenimento che abbia mai patito Genova in tutta la sua storia e, durata un anno, fu senz’altro l’epidemia di peste del 1656-7, descritta a san Gaetano e che ridusse la popolazione locale del 75%: non colera, ma peste; quella che nel genovesato vide rifulgere l’opera assistenziale del sestrese padre Antero; drammaticamente uguale a quella ‘manzoniana’ che però avvenne a Milano nel 1630, quando Genova allora ne fu preservata; dentro le mura di Genova, da 70mila anime ne erano rimaste 15mila (più alcune migliaia che erano riuscite a fuggire).
Da fonti storiche si sa che epidemie in Genova –di peste o colera o tifo- , da dopo l’anno mille e di gravi ne erano già venute sette: 1348, 1383, 1481, 1493, 1528, 1579, 1580, ma tutte meno aggressive rispetto quella del 1656.
Gli infettati, tipicamente erano dei disperati. Venivano innanzi tutto isolati in un lazzaretto -alla Fiumara (in genere le fosse comuni venivano scavate ai margini del mare, che col vento ‘depurava’ la zona) o al Campasso (ove è adesso il mercato dei polli), o ospitati nelle chiese (vedi san Gaetano in via Rolando, dove anche il 90% dei soccorritori, morì); senza assistenza specifica, e nella speranza –scarsa- di sopravvivere, non solo alla malattia ma anche a tutte le complicazioni allora sconosciute legate all’alimentazione, all’acqua, all’igiene, alla robustezza fisica, ecc.).
Tutto lascia quindi pensare che mentre vico dei Disperati ha una storicità, non altrettanto sia per “vico dei Dispersi”; o fu un lapsus tipografico, o calligrafico di quei tempi (le scritture a mano non sempre sono facilmente leggibili; e se anch’esso sempre riferito alla peste, fu dedicato a qualche imprecisato episodio di salvati di una famiglia distrutta o separatasi in conseguenza dell’evento.
Nel dic.1900 fu deciso dare alla strada ufficialmente la dedica a “via Pastrengo” .
BIBLIOGRAFIA
-Archivio Storico Comunale
-A.sconosciuto-Dattiloscritto parrocchia s.Gaetano-Bosco-vol.I.pag.85
-Gazzettino Sampierdarenase- 9/87.18 + 2/91.3 + 7/93.4
-Romano da Calice-La grande peste-Bullesi.1992-
-Tuvo.Campagnol-Storia di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.52